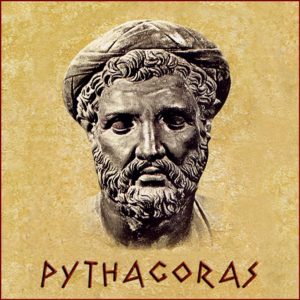Canterò, mia dolce Euridice, canterò perché niente ha più senso per me se non il canto, con cui cerco di lenire questo insopportabile tormento che è la mancanza di te, del tuo dolce riso, della luce e delle ombre che passavano nei tuoi occhi dallo sguardo innocente, delle tue danze leggiadre su letti di fiori e sulle rive dei ruscelli.
Dopo avere profondamente pianto Euridice sulla terra, Orfeo osò discendere fino allo Stige attraverso la porta di Tènaro e avanzando tra folle svolazzanti, tra i fantasmi dei defunti onorati di sepoltura, si presentò al signore dello spiacevole regno delle ombre Ade e a Persefone sua sposa. E facendo vibrare le corde della lira, così prese a dire cantando:
“O dèi del mondo che sta sottoterra, dove tutti veniamo a ricadere noi mortali creature senza distinzione, io non sono disceso qui per visitare il Tartaro buio. La ragione del mio viaggio è mia moglie, nel cui corpo una vipera calpestata ha iniettato veleno troncandone la giovane esistenza. Avrei voluto poter sopportare, e non posso dire di non aver tentato. Ma Amore ha vinto! E’ questo un dio ben noto lassù sulla terra; se lo è anche qui non so, ma spero di si; e se non è menzogna quanto si narra di un antico ratto, anche voi foste uniti da Amore”. [1]
Piangevano le anime esangui mentre egli diceva queste cose e accompagnava le parole col suono della lira. E Tantalo non cercò di afferrare l’acqua che rifluendo gli sfuggiva, e la ruota di Issione si arrestò, attonita, e gli avvoltoi smisero di beccare il fegato, e le nipoti di Belo lasciarono stare le brocche e tu, Sisifo, ti sedesti sul tuo macigno. Si narra che allora per la prima volta s’inumidirono di lacrime le guance delle Furie, commosse dal canto. E né la consorte del re, né il re stesso degli abissi ebbero cuore di opporre un rifiuto a quella preghiera; e chiamarono Euridice…
Orfeo, letteralmente Colui che è solo, è il nome del mitico poeta figlio di Apollo e della Musa Calliope, fondatore della setta Orfica, nata in Tracia nel V-IV sec. a.C.. Al centro della riflessione orfica (come in genere nei Misteri ed in particolare nei culti dedicati a Dioniso) stava l’enigma della morte e della risurrezione. L’epilogo del mito, infatti, in cui vediamo Orfeo che, pur sventrato, continua a cantare il suo amore, è un messaggio di fede nella salvezza eterna.
Forse è un po’ troppo paragonare le città d’Italia come un paesaggio surreale da “day after” in cui tutti gli Italiani sono invitati tassativamente a rimanere in casa e uscire solo per motivi indispensabili. Per quanto mi riguarda, quando esco per motivi necessari, come portare il mio cane a passeggiare o andare a fare la spesa, vedere altre persone che, come me, e a ragion veduta, rigorosamente manteniamo le distanze di sicurezza “contagio” nascosti dietro a una mascherina con le mani protette da guanti e per alcuni anche occhiali da sole per proteggere gli occhi fa un po’ impressione. Ci muoviamo tutti in un silenzio tombale e sembriamo fantasmi che si spostano silenziosamente per le strade avvolti da dubbi e paure. Sembra veramente di essere scesi nel mondo sotterraneo del dio Ade. E allora ecco che ci viene in soccorso l’arte di Orfeo: la musica per esorcizzare la paura e sentirsi meno soli.
La musica come terapia contro la paura. L’Italia reagisce cantando all’emergenza del mostro coronavirus che blinda tutti in casa. L’appuntamento, a una ventina di giorni dai blocchi che hanno fatto del Paese una zona rossa unica, o quasi, non è più nei locali o nei parchi, ma sul balcone delle nostre case, ognuno munito di ciò che ha a disposizione: padelle, tamburi, e coperchi per esorcizzare il mostro. Tutti affacciati dunque per intonare una canzone tutti insieme, e il risultato è una melodia, diversa per ogni quartiere e città, che attraversa le regioni da Nord a Sud, ora seguendo le note dell’Inno di Mameli, ora canticchiando “Napul’è” di Pino Daniele, Azzurro di Adriano Celentano
E’ la voglia di andare avanti, ANDRA’ TUTTO BENE, è questo lo slogan. Il cielo è sempre più blu!
FORZA ITALIA, TI RIALZERAI PIU’ FORTE DI PRIMA
[1] Pubio Ovidio Nasone – Metamorfosi, Libro X – Ed. Einaudi Torino 1979
Autrice: Manuela Mariani